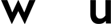MARIA VITTORIA BARAVELLI – LE SETTE VITE DI UNA CURATRICE
Originaria di Ravenna ma oggi a Milano, si è guadagnata il suo posto nella scena artistica (anche) utilizzando i social per avvicinare le persone, in particolare le più giovani, a un mondo da cui ci si può sentire distanti a priori
di Alessandra Lanza
Trent’anni ma un’anima antica, o meglio, più anime incontrate e raccolte in anni di storia recuperata – dell’arte, della letteratura, del mondo –, negli sguardi fotografici, nelle parole e nelle tracce di chi è passato prima di noi, ha provato i nostri stessi sentimenti e li ha resi con i simboli del proprio tempo, lasciando solchi in cui puntualmente ci ritroviamo. Maria Vittoria Baravelli, art sharer ravennate, curatrice richiestissima, feticista sentimentale (nel senso migliore del termine) del passato e della nostalgia di tutte quelle vite che non ha vissuto, se non nelle opere in cui sono state raccontate, crede che nella storia si possa rintracciare tutto quello che ci serve per vivere, ma che i sogni si declinino solo al futuro. «Abbiamo bisogno dell’avvenire per sentirci vivi».
Cosa sognavi di fare da bambina?
Di avere una “dolce fattoria” con un sacco di animali, la mia famiglia e le persone a cui volevo bene. Quando ho letto il Decamerone, anni dopo, ho capito che questa voglia di prendere le persone che amavo e metterle in un posto dove c’è sempre l’erba verde era un po’ quello che è stato il mio tormento è che è la mia vita: curarsi delle cose, curare il bello e, come dice Calvino, far sì che quello che non è inferno abbia un po’ di spazio. Che significa avere profondamente presente che cos’è brutto. Oggi sono meno rurale!
Sei diventata “art sharer” grazie a smartphone e social. Non avresti potuto farlo anche dalla provincia?
Sono di Ravenna, l’ultimo baluardo dell’impero. Non pensarla com’è oggi, ma con i suoi ori e colori d’Oriente, come Costantinopoli. Pasolini in una poesia la paragona a un tappeto orientale, magico, che ti permette di passare da un momento all’altro della Storia spostandosi da un marciapiede a un incrocio. Lì, però, non ci sarebbero stati l’apertura, la disponibilità, il coraggio e la libertà che puoi trovare in una grande città. È vero, anche in città non mancano i provincialismi, ma a Milano ho trovato tante persone adulte, tra cui molte donne, che hanno creduto in me quando avrebbero potuto non farlo, e questo mi commuove.
Oggi c’è ancora diffidenza nei confronti di chi usa questi mezzi per divulgare?
La diffidenza fa parte dell’essere umano: la combatto, ma non la contesto tour court. Per i latini il termine “transducere” (tradurre, NdR) non ha una neutralità di fondo, significa “andare oltre a un confine”. Il traduttore nell’antichità aveva la possibilità straordinaria di poter aggiungere del proprio al racconto, per renderlo più attuale. Non era una diminutio nei confronti dell’autore, ma un adattamento a un contesto diverso, per far esistere l’opera al meglio. Umberto Eco dice che i Promessi Sposi hanno solo avuto un po’ più culo dei dinosauri a non essersi estinti, che l’opera è aperta. Anche io la intendo così: per me la divulgazione è un modo di raccontare storie per avvicinare a una superficie che poi deve essere presidiata da altre persone.
Quanto è distante il tuo approccio divulgativo da quello che potremmo definire “classico”?
Non potrei mai raccontare la storia dell’arte come uno storico dell’arte o i monumenti della mia città come una guida turistica locale, ma spero di incuriosire qualcuno e spingerlo ad andare a Ravenna sulle orme di Pasolini o di Dante, anche se non l’ho scoperto né raccontato io per prima. Su una cosa sono tassativa: qualunque sia l’opera, richiede una presenza, perché nel momento in cui ti ci relazioni, esisti con l’opera. E non a caso l’arte, che è anche la cosa pubblica: mi piace vederla come qualcosa di politico. Politica e società richiedono partecipazione, l’arte richiede presenza.
Che cos’è che ti soddisfa di più dell’esperienza artistica?
L’arte ti fa capire cosa significa essere umani. Per il Cristianesimo la “compassione” è un dolore costante, per le altre culture copartecipacipazione. L’arte mi fa sentire umana perché mi fa empatizzare o reagire a cose che riguardano le vite che non sono la mia. Come quando vai a Parigi, cammini in Rue de l’Université e da una finestra vedi un trumeau, dei quadri, qualcosa lasciato per terra, e cominci a farti domande sulla vita di quelle persone, sui loro dispiaceri. L’anno scorso per lavoro mi hanno dato un piccolo appartamento affacciato sulla Tour Eiffel, da cui vedevo una signora cercare sempre qualcosa in un cassetto, e ho pensato che forse era solo disordinata, come me. Ecco, l’arte cerca di mettere un po’ di ordine nel disordine, dando la possibilità di capire altre vite, co-partecipare e sapere che in questo mondo rimani solo, però la forza degli altri diventa un’ottima armatura.
Quando hai capito che il tuo ruolo era in qualche modo “riconosciuto”?
Questo lavoro implica ricominciare sempre da zero e qualunque cosa tu faccia è l’antesignana di qualcosa che sarà ancora più sfidante. Anni fa la mia psicoterapeuta mi disse: «Lei ha l’ansia, ma riesce a mostrare che non è così». Insistette tanto che coniai il termine nonchalansia. Anche nei momenti più atroci sembro calma, al massimo preda di un fermento momentaneo, e tutti mi definiscono una persona solare: in realtà non lo sono per niente, ma proprio perché non lo sono cerco di far esistere un mondo con il sole.
Qual è la cosa più bizzarra che hai curato?
Una delle prime mostre che ho curato a Ravenna si chiamava IdDante, “Il volto di Dante per una tradizione contemporanea”. Il Prof. Rubioni dell’Università di Bologna, antropologo, si era preso la briga di ricostruire il volto del Poeta, dimostrando che era totalmente diverso rispetto alla fisiognomica che si è costruita attorno a lui. Abbiamo chiamato artisti contemporanei a ricrearne le fattezze: nessuno è riuscito a tenere fede al fatto che la verità fosse un’altra. Lo street artist brasiliano Kobra fissò un Dante molto istituzionale, facendo l’opera più classica che potesse fare. Siamo tutti un po’ ancorati al passato, al ritorno di un qualcosa che c’era prima.
E la più bella?
Tra le cose più belle c’è stato curare gli archivi di fotografia della Mondadori, in particolare le opere di Marisa Rastellini, la Vivian Maier italiana. Dietro quelle fotografie che hanno visto negli occhi la Rastellini abbiamo trovato il suo indirizzo. Oggi non c’è più traccia di lei, ma so che in quell’angolo del Lungo Tevere c’è una piazzetta e un palazzo dove ora ci sono notai e avvocati, ma dove una volta c’era una signora che portava lì Pasolini e le attrici per fotografarli. Ecco perché molte immagini erano scattate all’isola Tiberina! Come dice Michele Smargiassi, gli archivi sono galantuomini, perché rispondono. Tu devi fare solo le domande giuste.
Intervista pubblicata su WU 122 (novembre 2023)
La foto in alto di Maria Vittoria Baravelli è di Luis David Hernandez
Dello stesso autore
Alessandra Lanza
CONTENTS | 23 Ottobre 2025
‘SEARCHING FOR THE SAME LIGHT’ DI BARBARA PEACOCK
CONTENTS | 10 Luglio 2025
‘MEMORIE DEL TRANSITARE’ DI GRACE MARTELLA
CONTENTS | 5 Giugno 2025
‘LOOMING VALE’ DI LARS DUCHATEAU
CONTENTS | 29 Maggio 2025
MI AMI 2025, LE FOTO
CONTENTS | 20 Marzo 2025
‘GEOGRAFIE’ DI GIOVANNI CONVERTINO