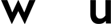MOGWAI – ANCORA IN PISTA
Abbiamo incontrato Stuart Braithwaite, fondatore della band scozzese prossima alla pubblicazione del suo nono album e che ha ormai superato i vent’anni di carriera. Ci ha parlato di cosa significhi essere ancora in giro dopo tutto questo tempo, e di come si venga a patti con certe antipatie
di Federico Sardo
I Mogwai sono uno dei gruppi cardine di quel non-genere che la stampa ha battezzato post-rock, termine che a loro non è mai andato troppo a genio, spesso identiIcato con la facile formuletta del “canzoni lunghe, strumentali, fatte di crescendo”. A settembre esce il nono lavoro del gruppo, Every Country’s Sun, pubblicato dalla loro stessa etichetta (la Rock Action), così incontriamo Stuart in una giornata dedicata alle interviste, il giorno dopo avere suonato come dj. Mentre sorseggia un calice di vino rosso, e ridendo molto, ci racconta di come cambiano le cose in vent’anni e di quanto ami ancora questa vita.
Cosa vi spinge dopo tutti questi anni a fare musica ed essere sempre in giro?
Mi piace davvero un sacco. Quando sei un musicista il tuo lavoro è di rendere migliore la vita della gente, o almeno provarci. E ci sono un sacco di belle esperienze, non mi sono mai annoiato di tutto questo. Ci sono elementi che sono meno divertenti, ma è normale nella vita, e c’è un sacco di gente che fa vite molto più difficili e fa cose orribili o noiose per guadagnare i soldi per pagare le bollette, quindi sono sicuramente un privilegiato.
Era il tuo sogno sin da ragazzino?
Non ho mai pensato di farlo per lavoro, ma ho sempre pensato di voler fare musica. Non ho mai neanche pensato troppo agli album o all’andare in tour, ma solo a voler fare musica. Poi le cose sono successe e va bene così.
Avete fatto un’anteprima del nuovo album con una specie di secret show al Primavera Sound, che impressione ne avete avuto? Immagino che quella possa essere una cosa ancora abbastanza emozionante.
Eravamo agitati, è una cosa inusuale, di solito non facciamo pezzi nuovi nché il disco non è praticamente fuori, ma è stato piacevole. Eravamo nervosi, volevamo vedere come andava. Il pubblico è stato co ed è rimasto no alla ne!
Era del tutto non annunciato, tipo «ma quelli sono i Mogwai»?
Non del tutto, è stato annunciato un paio di ore prima. Un vero e proprio last minute. È stato divertente.
Almeno dall’esterno, sembrate una band piuttosto libera da qualsiasi imposizione: avete la vostra etichetta, non cercate il singolo di successo… Vi sentite lo stesso intrappolati in qualche tipo di meccanismo o vi considerate liberi?
Io mi sento completamente libero. Pubblichiamo i nostri stessi dischi, se volessimo fare un disco jazz di cinque ore lo potremmo fare, sarebbe un’idea terribile, ma sarebbe comunque una nostra decisione. Non riesco a pensare a nessuna vera e propria restrizione, a essere onesto. Ci siamo creati un ambiente in cui siamo del tutto indipendenti: non abbiamo neanche un management, c’è giusto una persona che ci aiuta con alcune cose, ma abbiamo noi il controllo e non dobbiamo fare niente che non vogliamo.
Cosa pensi quando senti delle band che suonano esattamente come i Mogwai di un certo periodo? È un onore o ti arrabbi?
No, mi sento onorato. Quando eravamo più giovani e accadeva per le prime volte era strano, diciamo che non mi faceva felice, ma invecchiando ho capito che le band ci mettono un po’ per trovare il loro stile, ed è successo anche a noi. Ci vuole tempo per crescere, poi si trova una propria strada e si riescono a interpretare le proprie in uenze in modo più personale.
A chi vi ispiravate?
Volevamo suonare come i Joy Division o come i God Machine. E penso di poter dire che facevamo una versione veramente di merda di quelle due band.
Pensi che i vostri ultimi lavori siano stati un po’ oscurati dalla popolarità di certi dischi ormai classici?
Non del tutto. Penso che per la maggior parte delle band i primi dischi siano quelli che hanno il maggiore impatto culturale, però credo che siamo più popolari ora di un tempo, solo che ovviamente quando eravamo una cosa nuova poteva essere una storia più interessante. Però io sono molto orgoglioso e contento di come stanno andando anche i nostri ultimi lavori.
È molto stancante fare dei live come i vostri?
Più mentalmente che fisicamente. Siccome molti di noi ora hanno famiglia stiamo cercando di fare pezzi di tour meno lunghi, di non stare più in giro per magari nove settimane di la. Anche perché a quel punto hai il cervello in pappa, a volte non ti ricordi neanche che pezzo stai suonando. Però la gente vuole sempre che tu vada a suonare da loro, solo che non puoi suonare proprio ogni sera… Giriamo da così tanto tempo che ormai un po’ ti ricordi anche dei posti dove sei stato: per esempio un buon ristorante, un buon negozio di dischi o un museo da andare a vedere.
Odi ancora la definizione di post rock o ti sei abituato?
Sì, ormai ci sto venendo a patti. Sta uscendo un libro di Jeanette Leech, che si intitola Fearless, e il sottotitolo è The Making of Post Rock, però è un libro veramente fantastico. Ha intervistato un sacco di gente, gruppi veramente stupendi di cui non parla mai nessuno… Usa una definizione molto ampia del genere. Che è una cosa con cui vado molto più d’accordo. Mi dava fastidio quando era un termine popolare è che sembrava riferirsi a uno stile preciso che era il nostro, degli Explosions in the Sky e dei Godspeed. Gli Explosions in the Sky erano influenzati da noi e da altri gruppi, e a loro volta i Godspeed erano influenzati da alcune delle stesse band a cui ci ispiravamo noi: non siamo entrati in una stanza tutti insieme dicendo «Ehi, ora potremmo metterci a fare queste canzoni lunghe, con i crescendo…». È solo successo. Mi dava fastidio l’insinuazione di avere adottato uno stile invece di essere semplicemente una rock band che non aveva un buon cantante e quindi ci metteva poco cantato (ride, NdR). Inoltre è una definizione che toglie l’influenza di un sacco di musica importante come i Neu!, i Bark Psychosis, i Popol Vuh, i Goblin, Brian Eno… Si era arrivati al punto che quasi il termine implicava musica così intelligente da essere oltre il rock: non lo è, è rock solo un po’ diverso, come lo erano i Kraftwerk o i Joy Division. Preferirei sentirmi dire che siamo una band strana, ecco. Perché molto della nostra musica è solo strano, ed è quello il suo bello.
Originariamente pubblicato su WU 81 (settembre 2017). Segui Federico su Facebook.
La foto in apertura è di Bryan Sweeney
Dello stesso autore
Federico Sardo
CONTENTS | 10 Marzo 2022
SEMPRE CALDA, MA NEL WEB
INTERVIEWS | 15 Marzo 2018
FRANCESCO PACIFICO – CON L’ORECCHIO SUL TERRENO