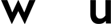SAID DOKINS – VOCI DELLA CITTÀ
Il racconto di un quartiere nelle parole dei suoi abitanti e un invito all’amore: è il murales realizzato da Said Dokins e da Spy sulle facciate di tre diversi palazzi, in via del Turchino, a Milano, per la prima edizione di Bloop Experience, progetto per la riqualificazione delle periferie e costola milanese dell’omonimo festival di Ibiza
di Elisa Zanetti
Nato a Città del Messico nel 1983, Said Dokins cela nel suo nome origini haitiane, l’amore paterno per le storie arabe e, nel secondo nome, Emmanuel, la cultura cristiana della madre. Influenze diverse caratterizzano anche il suo stile, che celebra in un’affascinante fusione di precisione, disciplina, espressività e spontaneità le tradizioni calligrafiche occidentale e asiatica, unite alla scrittura prefonetica. Le opere di Said Dokins hanno conquistato il panorama messicano e internazionale, con opere in Paesi come Australia, Spagna, Germania, Belgio, Regno Unito, Francia, Argentina, Cile, Brasile, El Salvador e Perù.
Com’è nata la tua passione per la calligrafia?
Ho iniziato a fare graffiti nel 1997, per strada, in città. Durante il mio percorso ho studiato anche arti visive, con particolare attenzione all’arte concettuale, e poi lettere e filosofia. Mi ha sempre appassionato esplorare formalmente, simbolicamente e filosoficamente la potenzialità di parole e lettere. Da qui il mio interesse per la calligrafia, il segno come gesto, la parola come immagine, l’espressività come linguaggio.
Ti sei sempre dedicato alla calligrafia o hai avuto anche una fase più figurativa?
Ho sempre lavorato con il testo, che è storicamente la base del graffito. C’è una relazione poderosa tra segno, immagine, parola e testo. Il nostro alfabeto ha origine nei pittogrammi, nei geroglifici. La scrittura prefonetica aveva già certe forme: per esempio la A è alpha, alpha è alep e alep significa toro. Se rovesciamo la A, come veniva scritta un tempo, possiamo immaginare la testa di un toro.
E tu usi anche i geroglifici?
Sì, lavoro con il geroglifico e lo porto a una calligrafia contemporanea, senza perdere la parte prefonetica. Nel caso di questo murales ho lavorato con lettere totalmente leggibili e altre illeggibili. Il mio lavoro ha sempre una parte criptica.

Il graffito “Ama” realizzato da Said Dokins e Spy in via del Turchino a Milano
Per quale ragione è presente?
È nella tradizione del graffito. Le persone tendono a rifiutare ciò che non si capisce bene e questo accade anche con il graffito, c’è però l’eredità della stilizzazione. Mi interessa di più la composizione e la pregnanza dell’opera nel suo insieme, piuttosto che quella di ogni singola parola. Lascio sempre indizi, alcune cose comprensibili, altre no, per fare sì che chi osserva si soffermi di più e possa apprezzare anche lo stile, il tratto, il colore.
Hai studiato calligrafia giapponese, occidentale, medievale… Come usi questi diversi stili?
Il mio stile ha molto a che fare con la mescolanza di tutte queste. Per esempio la calligrafia nella scrittura asiatica è lo shodo, che significa «cammino della scrittura». La scrittura occidentale invece è l’arte della bella scrittura, è una questione più aristocratica. Mi affascina prendere la calligrafia, massima espressione dell’aristocrazia, e portarla alla questione popolare, dentro al barrio. Della calligrafia giapponese mi piace il lato energetico: puoi spingere il pennello in tutte le direzioni. Provo sempre ad aumentare questa componente, mentre per quello che riguarda la struttura della lettera cerco di mescolarla con la lettera medievale, soprattutto gotica. Quando voglio un tratto più libero mi piace la corsiva perché è molto facile ed espressiva, la puoi allargare, fare più piccola… In base al progetto do un senso diverso a ogni mix.
Cosa hai scelto di fare per questo murales?
Il contesto nel quale lavoro lascia sempre un segno su ciò che sto facendo. Questo quartiere è molto particolare: le persone sono amichevoli, aperte, ma si nota anche che siamo in un contesto difficile, duro. Il muro dà un messaggio chiaro, positivo, che un po’ ha a che vedere con la speranza, nonostante le difficoltà esistenti: la parola che sarà più leggibile e che lascerà il segno su tutti e tre i muri è “ama”, l’imperativo del verbo amare. Poi c’è un secondo livello, rappresentato dalle parole suggerite direttamente dalle persone del quartiere, che si trovano sullo sfondo.
Il tuo lavoro ha una componente giornalistica: incontri le persone, racconti le loro storie…
La chiamerei “antropologia visuale” perché a volte sono parole, a volte sono oggetti che scambio con le persone e che inserisco nelle mie opere attaccandoli sul muro. Comunque sì, c’è qualcosa di giornalistico. Dal 2013 ho iniziato un progetto che sto replicando in diversi posti del mondo: chiedo a chi incontro di raccontarmi una storia sul luogo scegliendo una sola parola e poi la inserisco nel murales. Il dialogo è una componente fondamentale per capire il contesto ed entrare in contatto con la comunità, farne parte.
C’è stato un tempo in cui avevi smesso di realizzare graffiti…
Per un periodo mi sono concentrato di più su cose diverse, vicine all’arte concettuale e partecipativa, a performance, installazioni, arte site specific… E poi per due anni ho studiato filosofia. A un certo punto, però, ho pensato che non sarei voluto diventare un filosofo, perché la mia necessità è la produzione manuale, così sono tornato a operare nello spazio pubblico, ma con una nuova prospettiva, non realiz- zando più graffiti fuori dalla legalità, seguendo l’idea di un anarchismo individualista. Oggi, al posto che osservare le reazioni alle mie opere “non richieste”, ascolto prima le voci della città e le porto sul muro.

Said Dokins al lavoro sui dettagli, photo courtesy Bloop Experience
Com’è stato lavorare con un altro artista, Spy?
Generalmente le mie collaborazioni cercano di creare connessioni tra due stili, due mondi. In questo caso c’è stato un lavoro di squadra non solo con Spy, che si è occupato di realizzare le grandi lettere che compongono la parola “ama”, ma anche con il team di Biokip, che ho conosciuto l’anno scorso a Ibiza per Bloop Festival e che ha curato i rapporti qui a Milano. Credo che questo lavoro sia il risultato dell’unione di diverse forme di vedere, che ci ha portati a una stessa conclusione e a ottenere tutti insieme quest’opera.
Cosa ha imparato Said Dokins su questo quartiere?
C’è un insieme di culture molto interessante: ci sono italiani, asiatici, arabi… Non so se poi queste persone realmente si mescolino fra loro oppure no, però stanno convivendo insieme e sicuramente questo è un luogo di pluralità. Tutti parlano della pericolosità, della marginalità del quartiere, io credo che sia un aspetto, ma che si noti anche quanto è positiva la gente e questa è la parte cui io voglio dare riscatto: la capacità di amare.
Articolo pubblicato su WU 95 (aprile maggio 2018). La foto in apertura di Said Dokins è di Bloop.
Dello stesso autore
Elisa Zanetti
CONTENTS | 22 Aprile 2025
QUANDO SI LASCIA LA FAMIGLIA
CONTENTS | 22 Aprile 2025
DUECENTO SECONDI
CONTENTS | 18 Maggio 2023
LA GRANDE ASSENTE
CONTENTS | 15 Marzo 2023
FACCIAMO UN FIGLIO?
CONTENTS | 4 Gennaio 2023
DIETA DIGITALE