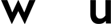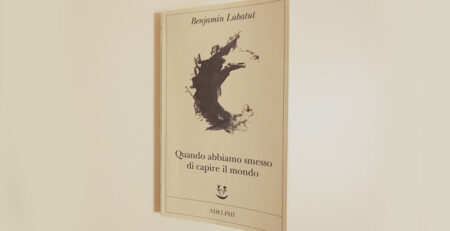ORGOGLIO MARANZA
Al festival di Cannes del 1995 Mathieu Kassovitz vince il premio per la miglior regia grazie al suo secondo lungometraggio, L’odio. 30 anni dopo, le vicende raccontate nel film restano attuali, come testimoniano uno spettacolo teatrale e il rap
di Luca Gricinella
Negli ultimi tre anni un termine gergale ha invaso prima i social media – a partire dalle pagine di costume sociale o specializzate in hip hop – e poi, di conseguenza, ha iniziato a essere citato sempre più spesso anche dai mass media fino ad arrivare ai politici (vedi il sindaco di Milano). Si tratta di “maranza”, appellativo con cui ormai chiunque identifica i giovani afrodiscendenti di periferia con un look piuttosto riconoscibile che parte dal cappellino da baseball griffato, passa dal borsello a tracolla sopra una tuta in acetato, e finisce con delle sneaker “importanti”. Nell’identikit, ormai di dominio pubblico, oltre all’outfit, si associano a questa categoria sociale anche l’ascolto e la produzione di due sottogeneri del rap piuttosto espliciti e molto in voga, la trap e la drill. Presto, però, ci si è messa di mezzo la cronaca e i maranza nell’immaginario popolare sono diventati soprattutto responsabili di vari fatti di microcriminalità, anche quando non c’erano prove della loro implicazione.
Molte persone, insomma, usano il termine in maniera dispregiativa associandolo a malefatte e soffermandosi sulle origini geografiche di questi ragazzi che, come capita spesso in questi casi, hanno iniziato a rivendicare con orgoglio questa loro identità. Sulla pagina Instagram del “Fronte maranza per la liberazione della Palestina” campeggia un verso tanto ironico quanto brillante in questo contesto, preso in prestito dal testo di Givova, brano di Speranza, rapper italo-francese di origine casertana: «Fors sbagliamm i modi, ma nu sbagliamm à moda». A presentarsi così, senza dubbio, è chi, oltre all’attenzione per il look, dimostra di avere una certa consapevolezza sociale e politica.
Lo scorso settembre è uscito anche in Italia l’ultimo saggio della scrittrice e militante antirazzista franco-algerina Houria Bouteldja che DeriveApprodi, la casa editrice che lo ha tradotto nella nostra lingua, ha deciso di intitolare Maranza di tutto il mondo, unitevi! – Per un’alleanza dei barbari nelle periferie. Nella nota editoriale all’inizio del libro si citano queste parole del rapper e scrittore romano di origine egiziana Amir Issaa: «Quello che accomuna i rapper di seconda generazione in Italia, in Francia o in Inghilterra, così come quelli che qui chiamano i maranza, è il sentirsi nel mirino, nemici della società, e rispondono con la provocazione». Poco dopo si parla di un sentimento di rabbia radicato, capace di persistere anche nei rapper affermati che si riconoscono in questa identità, come sembra dimostrare la storia di Baby Gang, anche in questo caso molto presente nella cronaca dai mass media.
Una cosa è certa e per capirla basta farsi un giro in certi quartieri delle città italiane in cui, da una via all’altra, si passa dal disagio al benessere. Che siano diventati rapper o meno, i maranza vivono realmente la strada e a volte basta che girino l’angolo per incrociare dei coetanei che esprimono una ricchezza per loro inaccessibile aprioristicamente a causa di un processo ben radicato che li esclude e discrimina sempre e comunque. Dalle case popolari di San Siro, dove risiedono molti rapper e maranza, alla zona che i dati IRPEF hanno identificato come la più ricca d’Italia, CityLife, per esempio, ci si arriva con una camminata di circa dieci minuti. Considerando che viviamo in un’epoca storica in cui c’è l’abuso del termine meritocrazia – concetto ben demolito dal professore di Harvard Michael J. Sandel, che ha dimostrato nei suoi scritti come l’uguaglianza delle opportunità sia impossibile – si può capire la genesi della frustrazione e quindi della rabbia e dell’orgoglio di questi ragazzi. Insomma, quando sono protagonisti di fatti di cronaca sgradevoli la domanda più sensata da farsi sarebbe: «Perché lo hanno fatto?» mentre, quasi sempre, ci si limita a chiedersi: «Da dove vengono?», omettendo che, in molti casi, alla fine si tratta di italiani, a prescindere dalle origini.
Detto ciò, se i maranza sono finiti al centro di articoli di cronaca, ma anche di costume e di musica così come di saggi politici e sociologici, significa che il fenomeno attira un interesse trasversale, a volte “basso”, altre “alto”. L’aspetto minimizzato è che sono gli unici (inconsapevoli) eredi di quelle che negli anni Ottanta e Novanta venivano definite “tribù metropolitane”, come i dark, i punk, i metallari e i paninari. E l’orgoglio, in alcuni casi mascherato, ha sempre fatto parte di chi sposava un look e un genere musicale per appartenere a un gruppo. Non è un caso, allora, che la parola maranza arrivi proprio dagli anni Ottanta, anche se all’epoca aveva un significato un po’ diverso, quasi equivalente al concetto di tamarro. A maggior ragione, il fatto che quando si parla dei maranza odierni si finisca quasi sempre per sottolineare o puntare il dito sulle loro origini geografiche, prima di tutto dice qualcosa su di noi più che su di loro.
In alto: un gruppo di giovani con look da maranza alla stazione di Rogoredo a Milano
Articolo pubblicato su WU 132 (giugno 2025)
Dello stesso autore
Luca Gricinella
CONTENTS | 15 Maggio 2025
L’ODIO NON MUORE MAI
CONTENTS | 12 Gennaio 2022
SOLO 120 NOTTI
CONTENTS | 18 Maggio 2018
PLASTIC DREAMS – AVERE VENT’ANNI AL TEMPO DEI RAVE